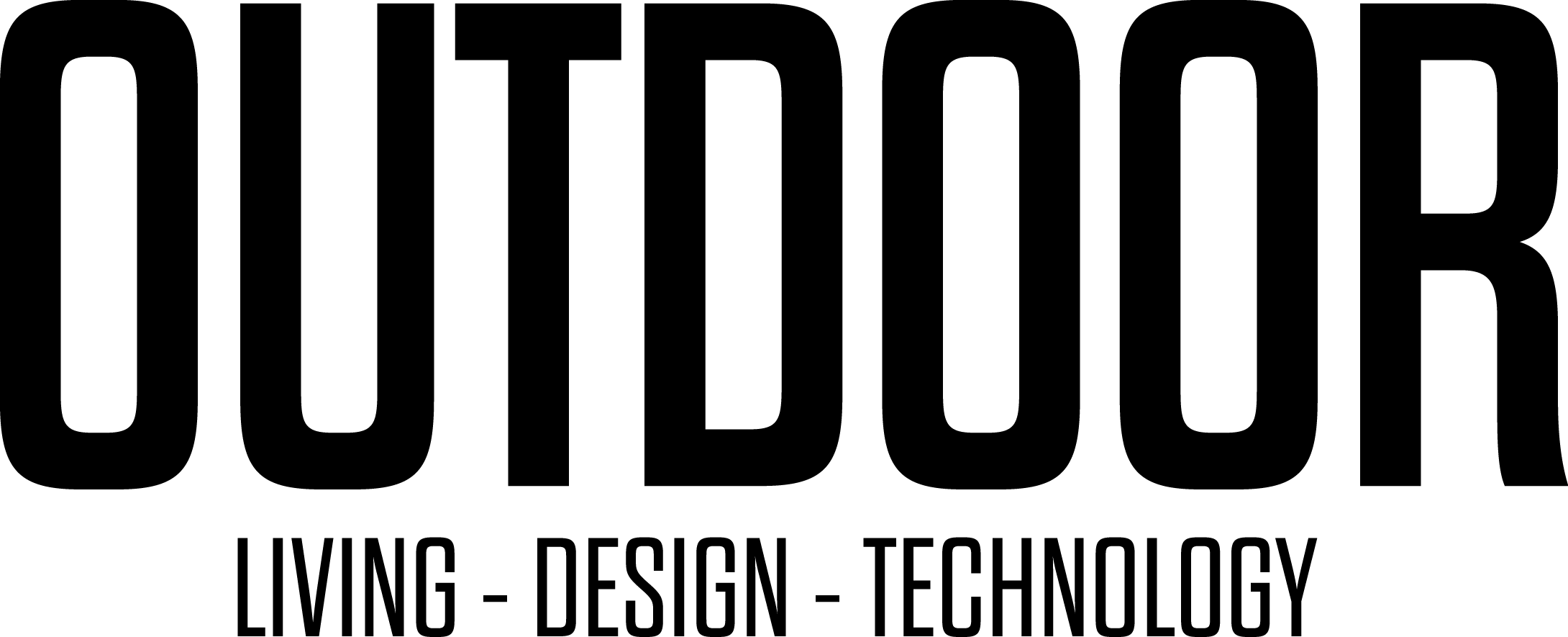I leggeri raduni dell’oggi. Reminiscenze classiche negli spazi di aggregazione
«Sosterrò le ragioni della leggerezza». È così che Italo Calvino dà il via a un individuale quanto universale dibattito sulla leggerezza nel suo scritto Lezioni americane (1988). Collocato, sempre stando a Calvino, «il valore della leggerezza nel presente», diviene lineare «(proiettarlo) nel futuro» conferendogli ruolo di materia, di contemporaneo quanto atemporale elemento da costruzione, di negativo di una storia che, varcata la soglia dell’oggi, deve farsi carico di quello stesso passato che lo ha generato. Il sapere, il “fare” architettura oggi, affonda le sue origini nel passato, ne coglie i tratti, ne estrapola le matrici, tramutandole nelle linee generatrici degli spazi che fanno parte della nostra quotidianità. Contemplare il passato, individuare un paragone tra “ieri” e “oggi”, diviene pretesto per osservare l’oggi coscienti della storia che ne è stata fondamento. Nello specifico, inteso lo “ieri” a cui fare riferimento coincidente con l’architettura romana, e l’“oggi” con quello delle contemporanee architetture dei raduni, si vuole ragionare su come queste ultime possano essere viste come il frutto di un misurato assemblarsi di cocci di storia, di frammenti di ieri. Delineato l’obiettivo, lo si vuole ora vestire e leggere tra le righe della “leggerezza”. Il “dare un peso”, il “pesare”, oggi, la leggerezza, tende a spogliarsi della sua potenza espressiva nel momento in cui questa si trova relegata al suo solo fine “fisico”. Svuotare l’architettura, metterne a fuoco i perimetri, delinearne i confini, fa di materia e vuoto i pesi
di una bilancia di cui architettura è l’ago. Inteso in questi termini, il vuoto, la leggerezza, frutto di una progressiva e misurata perdita di materia, assume un peso, custode di memorie ed esperienze passate. Ecco che allora le ottanta aperture a tutto sesto su tre ordini, perimetro in travertino del Colosseo (70 d.C.), svuotate e spogliate, sembrano anticipare le linee generatrici delle architetture di raduno “dell’oggi”. Lasciando lo sguardo puntato su Roma, un perimetro e involucro dei grandi raduni lo si intravede anche nelle massicce mura della Basilica Ulpia (113 d.C.) o di quella Costantiniana (326-333 d.C.). Queste, sgravate della loro massa, sembrano dettare le linee più sinuose e leggere delle architetture dell’oggi. Se Colosseo, Basilica Ulpia e Costantiniana sono del “contenitori”, altro tema interessante lo si ha nell’architettura “focus”, nei “perni” attorno cui radunarsi, nei “fulcri” dello spazio che diventano, alla stregua delle incisioni delle imprese di Traiano nell’omonima colonna (113 d.C.), pretesti narrativi. Si vogliono ora individuare tre progetti, tre architetture dell’oggi, che fanno da eco alle grandi architetture romane dei raduni, siano essi “contenitori” o “perni”.
Se essere fulcro di incontro, tramandare la storia e farsi carico della leggerezza del futuro che ne deve conseguire è il compito, House of The Pink Spot di Frankie Pappas ne è una delle possibili soluzioni che dal 2023 colora il suolo sudafricano di Orange Farm (Cape Town).

Sorto in una zona divenuta nel tempo scenario di violenze e atti vandalici, complice la scarsa illuminazione notturna e la minima attività umana, il roseo punto architettonico, fortemente voluto dal programma Digital Distruptors di Amnesty International South Africa, diventa pretesto per una rivitalizzazione dello spazio e una rigenerazione dell’area degradata, intrecciata a una conseguente riattivazione sociale e culturale dello spazio. Laterizi artigianali per i posti a sedere, legno dei pali del telefono, compensato e vernice, vernice rosa. Questi i materiali del progetto. Il resto, l’architettura, la fa il bilanciamento degli stessi tra il pieno e il vuoto. Tra il focus, e l’intorno. Tra l’essere spazio di raduno ed esserne suo segnale visivo. Se nove sono i metri quadrati su cui si impostano le ridotte dimensioni della struttura, di ben più ampio raggio è la folla che vi si raduna intorno.

Pensato e fortemente voluto dalla comunità come luogo di aggregazione, si fa scenario ora di grandi eventi, balli, feste, manifestazioni, ora di più intime e discrete attività umane. Il ruolo dell’architettura, in questo senso, diviene strumento di connessione e di pratica realizzazione dei servizi necessari alla riattivazione dello spazio. Se dal punto di vista degli “elementi architettonici”, House of The Pink Spot sembra relegato ai soli due elementi di struttura lignea e panche in laterizio, dal punto di vista dell’architettura intesa nella sua più ampia espressione, il progetto sudafricano crea una profonda connessione tra il luogo su cui sorge e la comunità che vi abita. Ecco che gli elementi del progetto non sono più solo pali in legno, pannelli in compensato e laterizi ma amplificano la loro utilità mescolandosi all’elemento comunità. È a questo ultimo “elemento architettonico” che si deve la messa in opera, la realizzazione pratica della struttura.

Ogni pezzo, ogni elemento, è stato assemblato e dipinto dai membri della comunità che, compresa la natura dell’opera che stavano realizzando, hanno vestito il “rosa” di un duplice significato: punto cromatico attrattivo e pretesto evocativo contro la violenza. Stando a Fernando Espuelas (Madre Materia, 2009), in architettura ci si avvia sempre più alla sostituzione della «presenza della materia con la produzione dei suoi effetti», virando delicatamente lo sguardo dalla «costruzione dell’oggetto al progetto delle sensazioni». Alzare e abbassare il volume della frivola musica su cui si muovono i passi degli abitanti di Orange Farm trasforma quindi l’elemento architettonico, ora in fondale per grandi raduni, ora in discreto spazio che avvolge le attività quotidiane.
Luogo: Drieziek, Sud Africa
Progettazione architettonica e paesaggistica: Frankie Pappas
Capo progetto: Ewald Jooste
Appaltatore principale: Siyakaya Construction
Tutte le immagini courtesy Frankie Pappas
Amplificando la scala, l’immateriale perimetro della Blue Court di Found Projects + Atelier Noirs racchiude, dal 2024, un frammento di costa di Xiangshan (Ningbo, Cina) trasformandolo in uno spazio dalle caleidoscopiche declinazioni.

Ora campo da basket, ora fulcro attorno cui sostare, socializzare, osservare l’oceano o trascorrere del tempo in quella “intimità naturale” di Carlos Martì Arìs (La centina e l’arco, 2007), che vede nello spazio pubblico, e nella natura da esso incorniciata, uno scenario per “i più intensi momenti”. Nello spazio aperto, nello spazio pubblico, sempre stando a Martì Arìs, la necessità di avere un confine viene del tutto dimenticata dalla presenza dello spazio pubblico stesso. Lo spazio della Blue Court, viene contemporaneamente definito e svuotato, complice la leggerezza calviniana che sembra allontanare drasticamente la Blue Court dal suo più primigenio antenato, incarnato dal perimetro massiccio dell’anfiteatro romano. Intesa la volontà di recintare uno spazio, all’interno del quale collocare una funzione “sportiva”, il suolo del perimetro, della cornice, si veste di contemporaneità nel momento in cui allo stesso perimetro sono affidate nuove funzioni.

La massa, elemento necessario per la stabilità dell’anfiteatro romano, cede ora il posto alla leggerezza, al vuoto. Non è necessario coprire lo spazio, non lo era nemmeno all’epoca dei romani. Non è necessario realizzare gallerie, arcovoli, gradonate. Il perimetro, qui, non serve. O meglio, serve nel momento in cui assume una funzione. Nella Blue Court, il perimetro si fa tettoia/spazio sotto e attorno cui sostare, radunarsi, osservare una partita di basket o la ben più poetica linea orizzontale dell’oceano. Se rosa era il Pink Spot africano, blu è quello cinese. Con i suoi 927 m2 di sviluppo in pianta, la “macchia” cromatica sulla costa, resa visibile e discreta proprio grazie al su perimetro, individua un’area “nuova”, un’area “diversa”. Il campo da basket poggia su un basamento in calcestruzzo armato, blu. A segnare l’ingresso, una tettoia sostenuta da cavi in acciaio, anch’essi blu, plasma il perimetro dello spazio. La volontà di alternare e intrecciare i cavi della maglia, ora più fitti, ora meno, è chiaro pretesto per rispondere, con un gioco di misurate trasparenze e leggerezze, alle sollecitazioni dei venti costieri.

Tre sono gli elementi architettonici individuati: la struttura primaria in acciaio, i cavi di tensione secondari e la rete metallica in acciaio. Fissati gli elementi “base”, all’architettura il compito di farli interagire. Stando all’architetto e saggista Johannes Duiker «è la costruzione a stabilire lo stile e i suoi valori […] (creando) una nuova architettura senza dilettantismi, ma appropriata e leggera soprattutto, piena di luce, di aria, di gioia di vivere» (Bouwkundig Weekblad, n.2, 1928, pp. 63-64). Ecco che allora la Blue Court diviene spazio pieno di luce, di aria e, nella sua forte natura cromatica, di gioia di vivere, trasformandosi in fulcro attrattivo per gli abitanti del luogo, reduci, vista la natura rurale del villaggio, di un importante fenomeno di spopolamento giovanile.
Luogo: Ningbo, Zhejiang, Cina
Committenti: The Government of Xiangshan County, The Government of Xinqiao Town, Ningbo City Bureau of Culture, Radio, Television, Tourism, and Sports of Xiangshan County, Bureau of Natural Resources and Planning of Xiangshan County, Transportation Bureau of Xiangshan County, Haibo Cultural and Sports Industry Development
Superficie edificata: 927 m2
Completamento: 2024
Progettazione: Found Projects, Atelier Noirs
Team di progetto: Miaojie Ted Zhang, Veronica Smith (Found Projects); Xinhao Li, Tianyu Kan, Weilun Chen (Atelier Noirs)
Istituto di design locale: Zhejiang Huazhi Design Institute
Appaltatore principale: Zhejiang Gutai Engineering
Consulente per l’illuminazione: ELA Lighting
Tutte le immagini courtesy Found Projects, Atelier Noirs
Intagliato. Frammentato. Svuotato. Questo il perimetro della Open Chapel di Christoph Hesse che sembra porsi in diretta opposizione a quelli ben più eterei e intangibili della House of The Pink Spot prima e della Blue Court poi.

Non è al perimetro che qui viene affidato il compito della leggerezza. Qui, la leggerezza si incarna a terra e a cielo. Se con la Basilica Ulpia e la sua discendente Basilica Lateranense si gettano le basi per gli elementi “chiave” dell’archetipo della basilica, con la Open Chapel tali elementi, seppur riconoscibili, si vestono di un “peso” differente. A Hillershausen (Germania), delicatamente poggiata su una collina, la Open Chapel si modella su uno schema in pianta che evoca delle mani giunte e si innalza verso l’alto per 6 metri con materici setti in arenaria, misuratamente distanziati tra loro. Ispirata agli “Open Mind Places” del vicino villaggio di Referinghausen (Sauerland), il perimetro della Open Chapel racchiude uno spazio di raduno e di ritrovo, sia individuale che collettivo. La dicotomia raduno-individuale, apparentemente priva di significato, permette di ragionare sulla volontà dell’architetto di creare uno spazio in cui la connessione uomo-natura sia amplificata, resa possibile sia dalla natura “evocativa” dello spazio, sia dalle scelte architettoniche stesse.

I “tagli” nel perimetro, svuotato e intervallato da nicchie, altro non sono che pretesto per creare dei punti di vista sul paesaggio circostante. Il pavimento, realizzato con uno strato di trucioli, altro non è che elemento per garantire una continuità materica tra interno ed esterno, pur segnandone la differenza. Alla stregua di pavimento e pareti, il soffitto si veste di libertà, staccandosi da queste ultime e creando angoli visuali verso l’esterno. La connessione, la complicità tra architettura e natura si concretizza nella Open Chapel con soli due materiali, lasciando, ancora una volta, all’uomo il compito di portarla alla sua massima espressione. Se leggerezza era il “fil rouge”, la volontà di mettere in confronto le architetture dell’oggi, della contemporaneità, dei raduni, con quelle del passato ne è stata la chiave di lettura. Intesa la leggerezza, la perdita di materia, a cui non è da associare una conseguente perdita di significato, uno dei “nuovi” materiali dell’architettura, la sua origine getta le sue radici in quell’architetture del passato di cui Colosseo, basiliche e colonne solo alcuni esempi. L’operazione di “svuotare” come afferma Calvino, non mette necessariamente la leggerezza a un livello superiore o inferiore rispetto al “peso”. Trattasi delle due facce della stessa medaglia, così come la «pesantezza della pietra può essere rovesciata dal suo contrario» (Lezioni americane), allo stesso modo, se non consapevole, la leggerezza può perdersi, può perdere il suo valore se non frutto di un «alleggerimento consapevole».

Che sia la colonna di Traiano, o la House of The Pink Spot, il Colosseo o la Blue Court, la basilica o la Open Chapel, la volontà e il tentativo di radunare persone attorno o all’interno di un’architettura getta le sue origini nel passato. Ecco che allora la “leggerezza” dell’oggi, può essere tale solo se frutto della “pesantezza” del passato. Radunare persone oggi, radunare persone ieri fanno capo alla stessa volontà di intenti. È l’architettura, con la declinazione dei suoi materiali, che ne plasma la forma. Che siano pali rosa del telefono, gettate di cemento blu, o setti in arenaria, materia comune di questi spazi resta impregnata nella comunità. Parlare di spazi per i raduni porta a parlare dell’Uomo, e della sua primigenia connessione con l’architettura, insita, volente o nolente, nell’architettura stessa. Alla materia e al suo plasmarsi secondo le necessità, il compito di disegnare gli spazi dell’oggi; alla leggerezza, a quell’“invisibile peso”, il compito di definirne la forza espressiva.
Luogo: Hillershausen, Germania
Committente: Bergkapelle Hillershausen
Superficie: 50 m2
Completamento: 2024
Architetto: Christoph Hesse Architects
Collaboratori: comunità locale, Groß & Wilke
Fotografie: Laurian Ghinitoiu
Tutte le immagini courtesy Christoph Hesse Architects
Giorgia Benedetti
- courtesy Frankie Pappas
- courtesy Frankie Pappas
- courtesy Frankie Pappas
- courtesy Frankie Pappas
- Found Projects, Atelier Noirs
- Found Projects, Atelier Noirs
- Found Projects, Atelier Noirs
- Found Projects, Atelier Noirs
- © Laurian Ghinitoiu
- © Laurian Ghinitoiu
- © Laurian Ghinitoiu
- © Christoph Hesse Architects
- © Laurian Ghinitoiu
- © Laurian Ghinitoiu
- © Christoph Hesse Architects